
Mi sembra di vedere la vostra faccia che, dopo aver letto il titolo di questo intervento, si fa più corrucciata, quasi incredula.
Alcuni di voi mi penseranno in preda a un delirio strano, magari di influenza nazista, ma vi posso assicurare che sto bene.
Non sono uno storico, né un filosofo o chissà cos’altro. Però, negli ultimi due anni, ho letto molto sull’argomento e, soprattutto, ho imparato a consultare le fonti giuste, non Wikipedia.
Le modalità con cui viene celebrato il 27 gennaio hanno poco o nulla a che fare con la storia.
E dobbiamo avere l’onestà intellettuale di ammetterlo.
Ce lo spiega bene Sergei Loznitsa, regista ucraino, che nel film “Austerlitz” ci mostra quello che accade quando il turismo di massa incontra un luogo bisognoso di rispetto come il campo di concentramento di Sachsenhausen, non molto distante da Berlino.
Gente che si fa un selfie con dietro la scritta “Arbeit macht frei” o che bivacca per fare uno spuntino davanti alle camere a gas, per non parlare di quello che si fa scattare una foto nel piazzale delle esecuzioni, fingendo di essere legato ad un palo…
La parola “Shoah” è divenuta sinonimo di profitto, mentre nomi e luoghi usati in maniera assolutamente strumentale dai media compiono sforzi immani per darci esattamente quello che cerchiamo: un’emozione.
Già, un’emozione. Perché da soli non siamo più capaci di provarne, se non grazie alle coordinate che ci vengono preimpostate dall’esterno, da qualcun altro, come fossimo un navigatore satellitare.
E così, siamo riusciti a “brandizzare” anche la morte, nella logica conseguenza di una società che per troppi anni ha preferito spettacolarizzare questo fatto storico, relegando la riflessione critica a mera polvere da nascondere sotto il tappeto.
Mitizzare e circoscrivere sul calendario un accaduto, però, è il primo passo per svuotarlo dal proprio significato, con grande gioia dei movimenti nazionalisti ed estremisti. Sì, perché non dobbiamo dimenticarci che, in un cono d’ombra sempre meno nascosto, queste persone spinte da una chiara ideologia politica avanzano nel loro proselitismo, esattamente con le stesse modalità sradicalizzanti: spacciando per “cultura” il negazionismo e l’antisemitismo, sdoganandoli in particolar modo sul web e tra i giovani, a cui bisognerebbe insegnare, fin dai primi giorni di scuola, ad avere un approccio più diffidente e selettivo verso le tonnellate di spazzatura che circolano in rete.
Per questo ho iniziato l’articolo con un titolo provocatorio.
Il 27 gennaio non può rappresentare la strada più semplice per rimuovere un debito collettivo che, come umanità, abbiamo in sospeso con noi stessi.
Perché il nodo della questione è proprio qui: abbiamo trasformato una giornata, che dovrebbe essere dedicata all’autocoscienza dell’Europa, in occasione per divulgare una storia stereotipata con protagonisti 6 milioni di ebrei.
Ma la vera finalità della ricorrenza non è questa, bensì quella di appropriarsi dell’evento stesso, di sentirlo come qualcosa che indissolubilmente fa parte della nostra storia di cittadini italiani, tedeschi, europei.
Non è quindi stringendo la mano alla comunità ebraica che gli si rende giustizia, ma comprendendo e riconoscendosi in quello che è accaduto.
Per finire, vi voglio lasciare con un frase emblematica di Elena Loewenthal, raffinata scrittrice di origine ebraica, contenuta nel suo saggio “Contro il giorno della memoria” e che, a mio giudizio, riassume bene quanto ho cercato di esprimere fino ad ora.
“Gli ebrei ci hanno messo le vittime, i morti e i sopravvissuti. Una storia subita non ti appartiene mai. È di chi impone il sopruso. E non è mai sacra. Nessuna storia è sacra. Neanche la memoria lo è. È umana, ma non per questo va strapazzata, dismessa, deviata e negata.” (Elena Loewenthal, “Contro il giorno della memoria” – Ed. ADD, 2014)
Alcune immagini del docu-film di Sergei Loznitsa
Per approfondire l’argomento:
- Un’utilissima riflessione di Francesca Recchia Luciani, filosofa e docente all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- “Contro il giorno della memoria” di Elena Loewenthal (Ed. ADD, 2014)
- “Pop Shoah?” di Francesca Recchia Luciani e Claudio Vercelli (Ed. Il nuovo Melangolo, 2016)
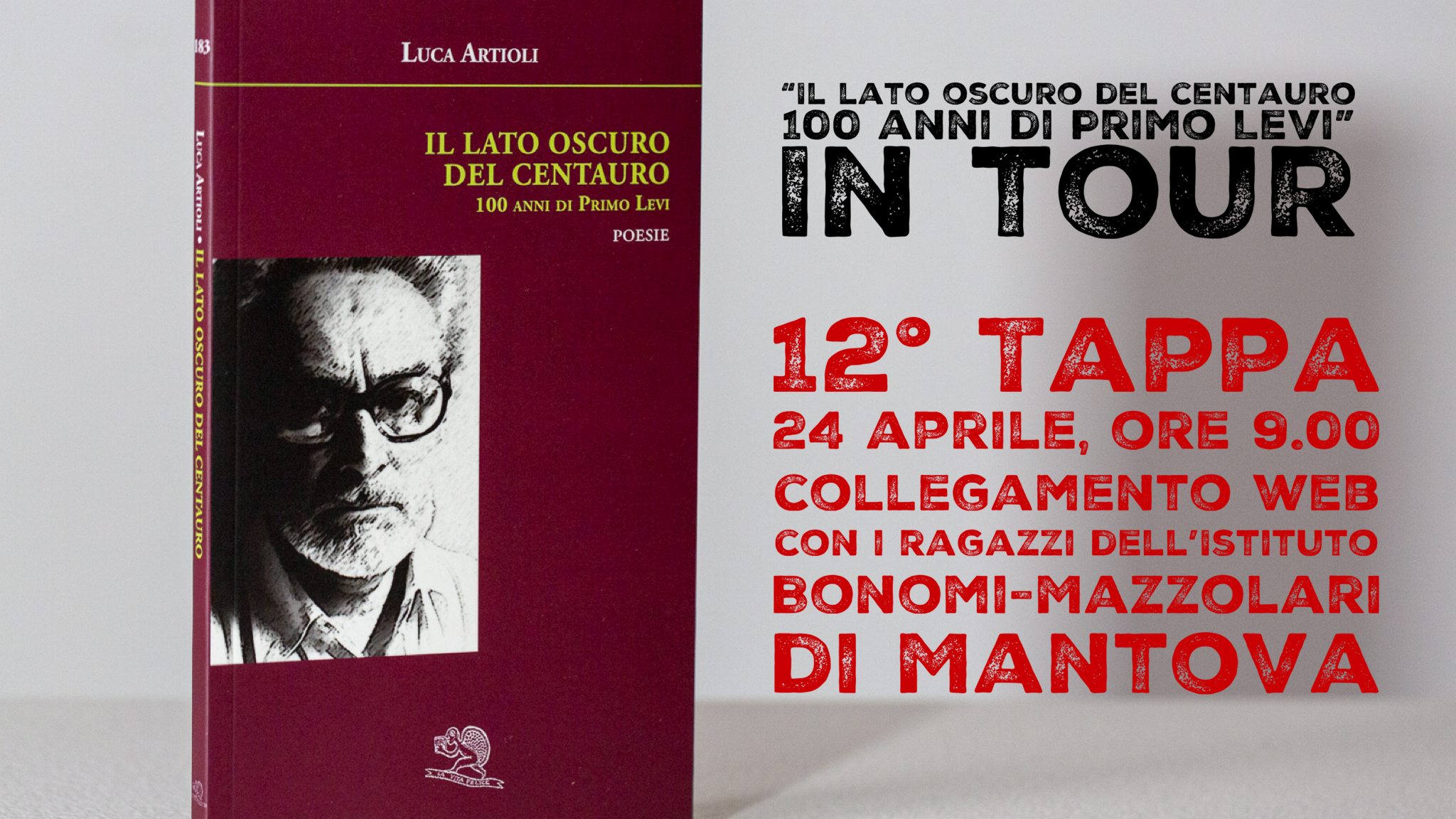
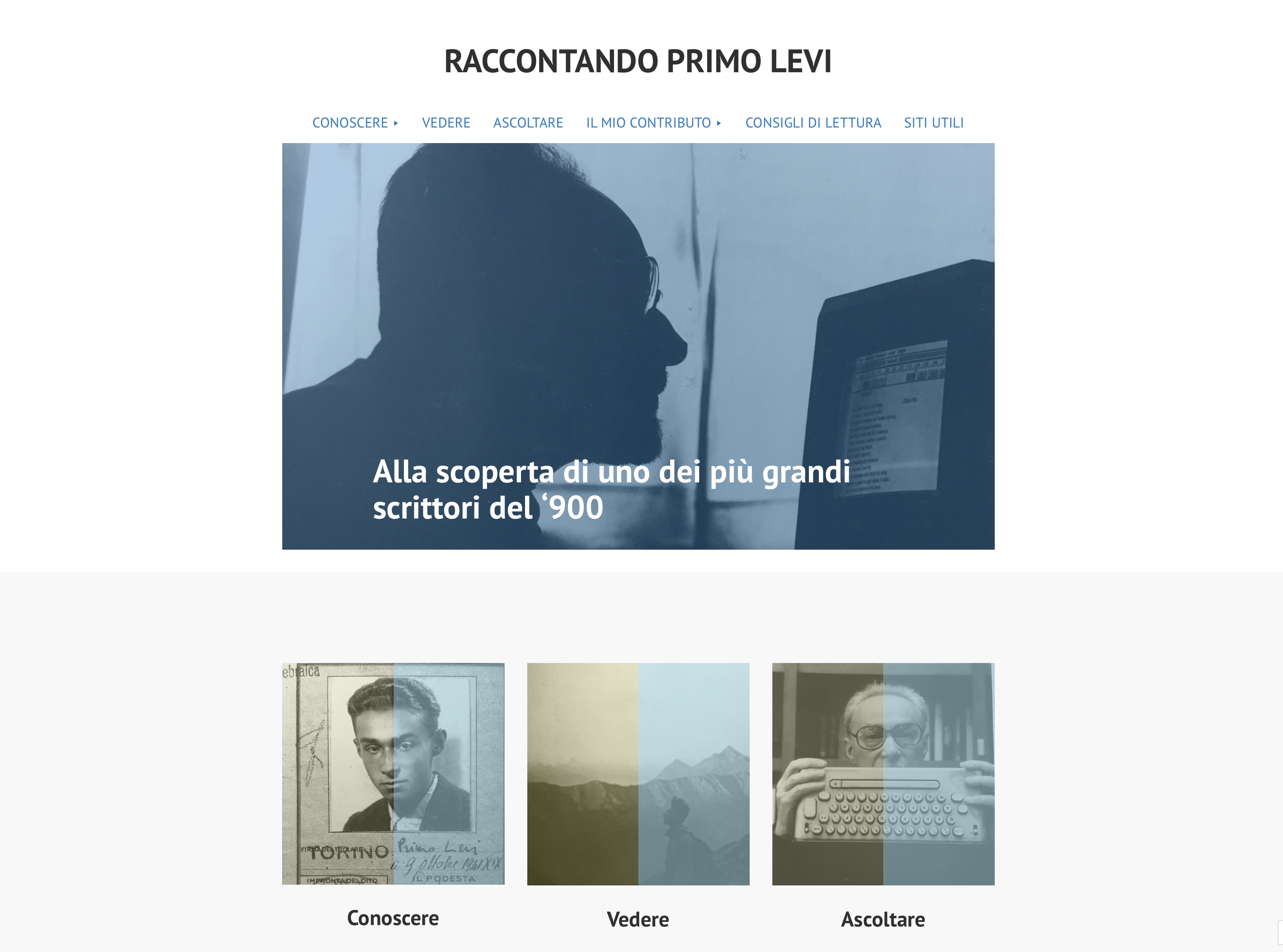

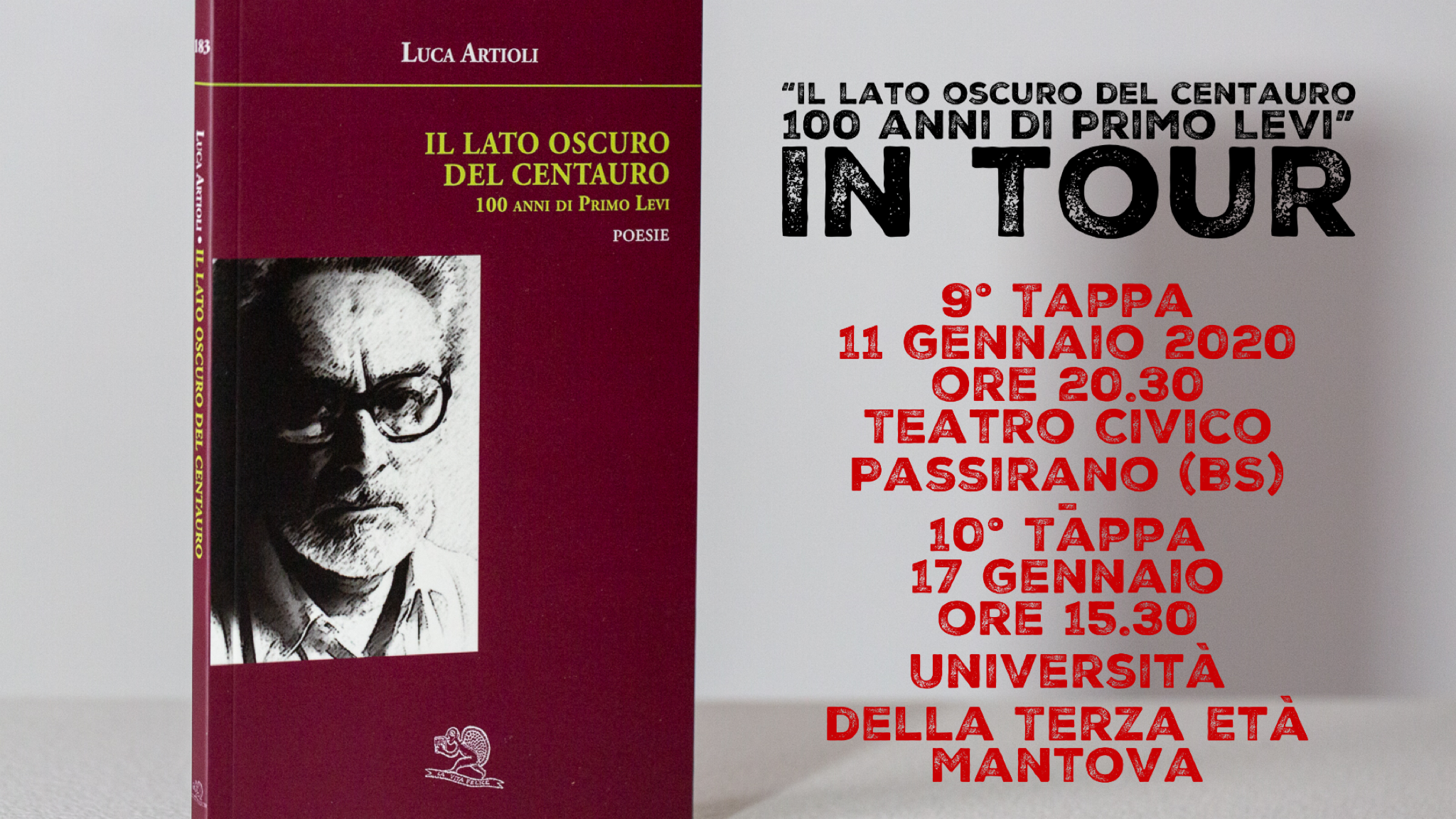
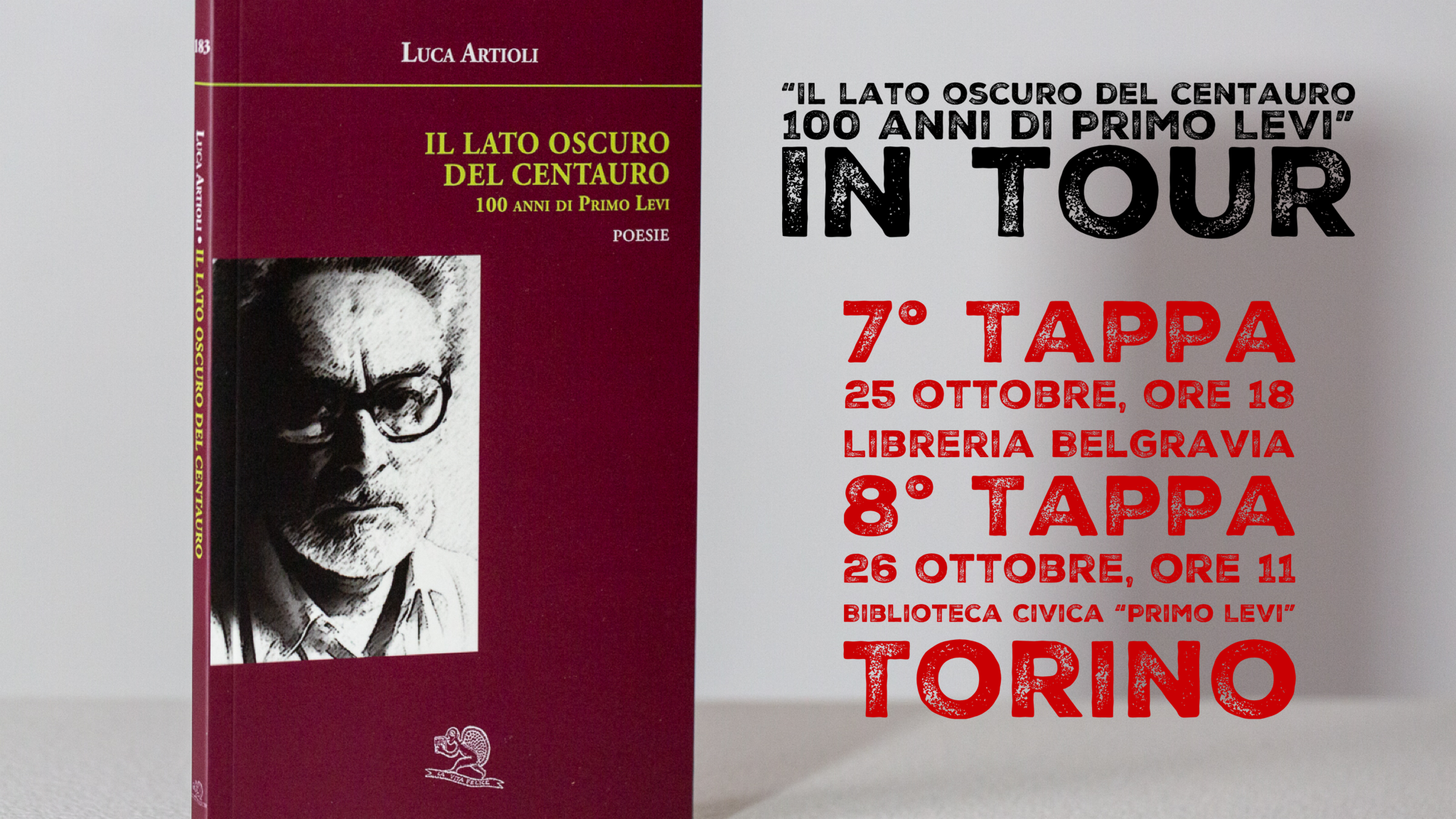

fuori dal coro qualunquista, tu. Condiviso e sentito. Grazie
Grazie anima bella! 😉
Sarebbe necessario chiarire cosa si debba intendere per “sacro”. È un termine che deriva da “sacrificio” e indica l’essersi sacrificato del Mistero trascendente nel riflettere il suo essere Libertà assoluta – che non può contraddirsi – nella libertà relativa concessaci. Naturalmente la Realtà assoluta non può sacrificarsi, questo perché essendo causa delle cause… nulla che sia un suo effetto potrebbe modificarla, ma la sua riflessione nella relatività è intesa come fosse un sacrificio, perché implica un diminuire la propria assolutezza dandole una forma, anche se capovolta. Per questo in India è la lacrima il motivo decorativo più comune. È sacro tutto ciò che implica il sacrificio di sé, ma non quando esso è imposto. Deve sempre essere una scelta consapevole di chi ha deciso di percorrere a ritroso la propria esistenza, facendolo attraverso il sacrificio del proprio ego. La storia racconta del sacrificio e non può essere sacra.
Dovresti affrontare questo tema con Elena Loewenthal.
Per quanto mi riguarda, se il “sacrificio” è figlio di una scelta… questa è figlia, a sua volta, di una libertà.
Da qui il tuo “non imposto” collima.
Salvo poi intendere la storia come un “tempo che avviene”, indipendentemente dalla volontà del singolo.
Questo ragionamento può vedere quindi la storia come “imposta”, dunque mai sacra.
Ma è una mia interpretazione, magari diversa da quella dell’autrice del libro summenzionato.
Detto questo, credo che il punctum del mio articolo sia incentrato su altri aspetti.