
Nei precedenti approfondimenti, abbiamo provato a fare chiarezza sulla nascita dell’eugenetica (“Hitler e il cugino di Darwin“) e di capire quali furono le ragioni che portarono all’ascesa del nazismo (“Manuale del perfetto nazista“).
Temporalmente, fra i due avvenimenti, possiamo individuare però un altro spunto interessante di discussione: il plagio del popolo tedesco sulla questione della razza e la conseguente accettazione dell’eutanasia come metodo di pulizia sociale.
Ma vediamo nel dettaglio quali strumenti vennero messi in atto per raggiungere questo risultato dalle conseguenze infauste.
“La morte non è un evento della vita. La morte non si vive”. (L. Wittgunstein)
LIBRI
Nel 1920, lo psichiatra Alfred Hoche ed il giurista Karl Binding pubblicarono un libretto dal titolo inequivocabile “Il permesso di annientare vite indegne di essere vissute“, nel quale si cercava -per fini utilitaristici- di giustificare la soppressione di persone mentalmente o intellettualmente morte.
Le stime di allora affermavano che circa il 10% della popolazione fosse affetta da malattie inguaribili, malattie che li rendevano semplicemente una “zavorra” di nessun valore per la società, già colpita duramente sotto l’aspetto economico dagli esiti del primo conflitto mondiale.
Ciò che doveva essere una questione medica, insomma, assunse ben presto una connotazione politica, finanziaria e sociale.
Ecco spiegato lo scopo utilitaristico: i soldi erano pochi, pochissimi, per cui le cliniche venivano invitate ad investire a favore dei cittadini produttivi, nel pieno rispetto di quel “dovere germanico” che si impegnava al miglioramento della razza.
In questo modo, però, si metteva in subordine il compito stesso della medicina, cioè di sostenere il diritto alla vita, così come quello del medico, il quale dovrebbe avere il compito di riconoscere la malattia in quanto parte della vita, di curarla laddove possibile, ma mai di volerla eliminare assieme alla vita stessa.
L’opera scatenò inevitabilmente discussioni e polemiche nel Paese, soprattutto nelle regioni dove l’influenza della Chiesa cattolica si avvertiva maggiormente, mentre il movimento eugenetico tedesco iniziava a mostrare quello che sarebbe stato il proprio impulso radicale, la propria deriva brutale.
SCUOLA
Nel 1923, l’Università di Monaco di Baviera istituì la prima cattedra di “Igiene della razza“, affidandola a Fritz Lenz, un genetista tedesco con all’attivo numerosi articoli incentrati sulla biologia razziale e sociale.
Le teorie di Lenz sulla “razza come principio” fornirono una giustificazione scientifica a quella ideologia nazista che stava velocemente prendendo forma; in particolare, la sua enfasi sulla superiorità della “razza nordica” e l’opportunità di eliminare ceppi presumibilmente inferiori dell’umanità, ne fecero presto un punto di riferimento imprescindibile per i simpatizzanti del nazionalsocialismo.
Ma il termine “igiene razziale” non fu coniato da Fritz Lenz, bensì da Alfred Ploetz, un genetista che, con lo stesso Lenz e lo psichiatra Ernst Rudin, faceva parte del cosiddetto “gruppo di Monaco“, l’espressione più estrema e distorta delle teorie eugenetiche.
Ploetz sosteneva che i progressi della medicina avrebbero paradossalmente protetto la vita dei minorati, gli stessi che lui avrebbe mandato “al fronte come carne da cannone, risparmiando gli esemplari più validi”.
Spalleggiato da Hitler, fondò la “Società per l’igiene razziale”, che nel suo programma stabiliva: esame medico prematrimoniale obbligatorio, impedimento della riproduzione degli anti-sociali tramite segregazione in colonie di lavoro, organizzazione di un registro di sanità per la popolazione, esami medici per tutti al fine di attestare la qualità razziale, nonché insegnamento dell’igiene razziale nelle scuole superiori.
Risultava chiaro, quindi, l’intento subdolo con il quale si cercava di influenzare il percorso pedagogico delle nuove generazioni.
Nel 1940, il concetto di “eutanasia” venne propinato perfino ai bambini delle elementari sotto forma di problema matematico, dove si chiedeva agli alunni di calcolare quanto venisse a costare allo Stato il gravoso mantenimento dei disabili e dei malati di mente.

La locandina del film
CINEMA
Era il 1941, quando nelle sale uscì uno dei più controversi film della storia del cinema: “Ich klage an” (“Io accuso“), diretto da Wolfgang Liebeneiner, con il supporto del ministero della propaganda nazista.
La trama vede una giovane e vivace protagonista che scopre improvvisamente di essere malata di sclerosi multipla. Il marito, medico, dopo aver tentato inutilmente di trovare una cura, acconsente alla volontà della donna che gli chiede di aiutarla a morire, affrontando poi il processo per omicidio a testa alta.
Lo spettatore si trova perciò catapultato in una storia commovente, in grado di ipnotizzarlo e di far leva su quel senso di pietas che libera dal dolore. Ci si commuove, insomma, e poi si finisce per approvare la scelta del medico; ma il messaggio che passa nasconde un inganno, un inganno in grado di andare oltre la mera questione delle coscienza morale di fronte ad un caso come questo.
E la propaganda nazista lo sapeva perfettamente.
Era consapevole che, grazie a quell’adesione spontanea del pubblico, si sarebbe potuto giocare in futuro anche l’accettazione di una morte, soprattutto per chi fosse stato ritenuto di nessuna utilità sociale.
E IN ITALIA?
Se la politica eugenetica tedesca risentì della sua deprecabile deriva, lo si deve probabilmente anche al contributo di alcuni studiosi italiani, pionieri di certe discipline scientifiche dai dubbi fondamenti.
Nel 1891, ad esempio, nacque la rivista “Scuola Positiva” ad opera di Enrico Ferri e Cesare Lombroso.
Mentre quest’ultimo indagò sui fattori fisiologici che spingevano alla criminalità prendendo le misure ai crani delle persone, il primo si concentrò sui fattori sociali ed economici, nella convinzione che fosse la stessa “selezione naturale” a rendere doveroso il sacrificio dell’individuo per il bene della società, sancendo la superiorità della collettività sul singolo e chiedendo l’introduzione di quegli stessi provvedimenti voluti poi qualche decennio dopo da Ploetz, come il certificato prematrimoniale, la sterilizzazione, ecc.
E come non ritrovare i concetti di Hoche e Binding nelle parole di Enrico Morselli, psichiatra e antropologo, che nel 1923 dichiarava: “A prescindere dallo scopo umanissimo di far terminare prima dell’ora quei patimenti, vi sarebbe nell’eutanasia anche un fine utilitario; anzi, secondo taluni, esso dovrebbe primeggiare, in quanto quella massa di invalidi non rappresenta più alcun valore né per le famiglie né per la collettività, e questa non ne ha che un gravame parassitario dovuto alle spese per ricoverarli ed assisterli. Specialmente si prospetta un siffatto provvedimento di risparmi di fronte al sempre più grosso dispendio che le nazioni civili si sono a poco a poco accollate per il mantenimento dei pazzi cronici”.
La vita dell’uomo rimane inviolabile perché egli è una persona. E l’essere persona non è un dato di natura psicologica, ma esistenziale, ontologico, che non dipende né dall’età, né dallo stato di sviluppo, né dallo stato di salute, né dalla condizione psicologica in cui egli si trova. (G. Brambilla, “Il mito dell’uomo perfetto“)
CONCLUSIONI
Il quadro che si viene dunque a determinare, dopo questo breve excursus, risulta essere complesso e per nulla semplice da sviscerare.
La Germania è stata la culla del nazismo, rielaborando in chiave radicale e violenta quella dottrina eugenetica che, dalla seconda metà dell’ottocento, aveva sì trovato interpreti e proseliti in Italia, ma anche negli Stati Uniti e in gran parte dell’Europa del nord, seppur con esiti meno nefasti.
Il tessuto sociale tedesco si lasciò pervadere da una mentalità distorta e strumentalizzata, dove a tirare i fili di questo vero e proprio plagio furono quegli stessi uomini di scienza, che nulla fecero per ostentare la propria vicinanza a ideologie politiche nazionaliste.
La vita umana veniva quindi concepita nel suo esclusivo “valore d’uso”, così da poter essere disposta come un mezzo, e non nel suo “valore di fine”, capace di escludere ogni sfruttamento ed esigere che ogni ricerca, sperimentazione e intervento, potessero concretizzarsi in un suo maggior beneficio.
E su questo aspetto non bisognerebbe mai smettere di riflettere, perché troppo spesso tale matrice comportamentale tende a replicarsi nel nostro vivere quotidiano, facendoci perdere di vista quel necessario superamento della sfera “dell’io” per abbracciare una sfera del “tu”. Una dimensione che nell’incontro dell’altro permette ad ognuno di noi di realizzarsi come essere umano, tenendo lontano quell’assuefazione alla morte tanto odiosa, quanto innaturale.
©Luca Artioli (marzo, 2017)

Suggerimento di lettura:
- “Vittime dimenticate” di Giorgio Giannini (Ed. Stampa Alternativa, 2011)
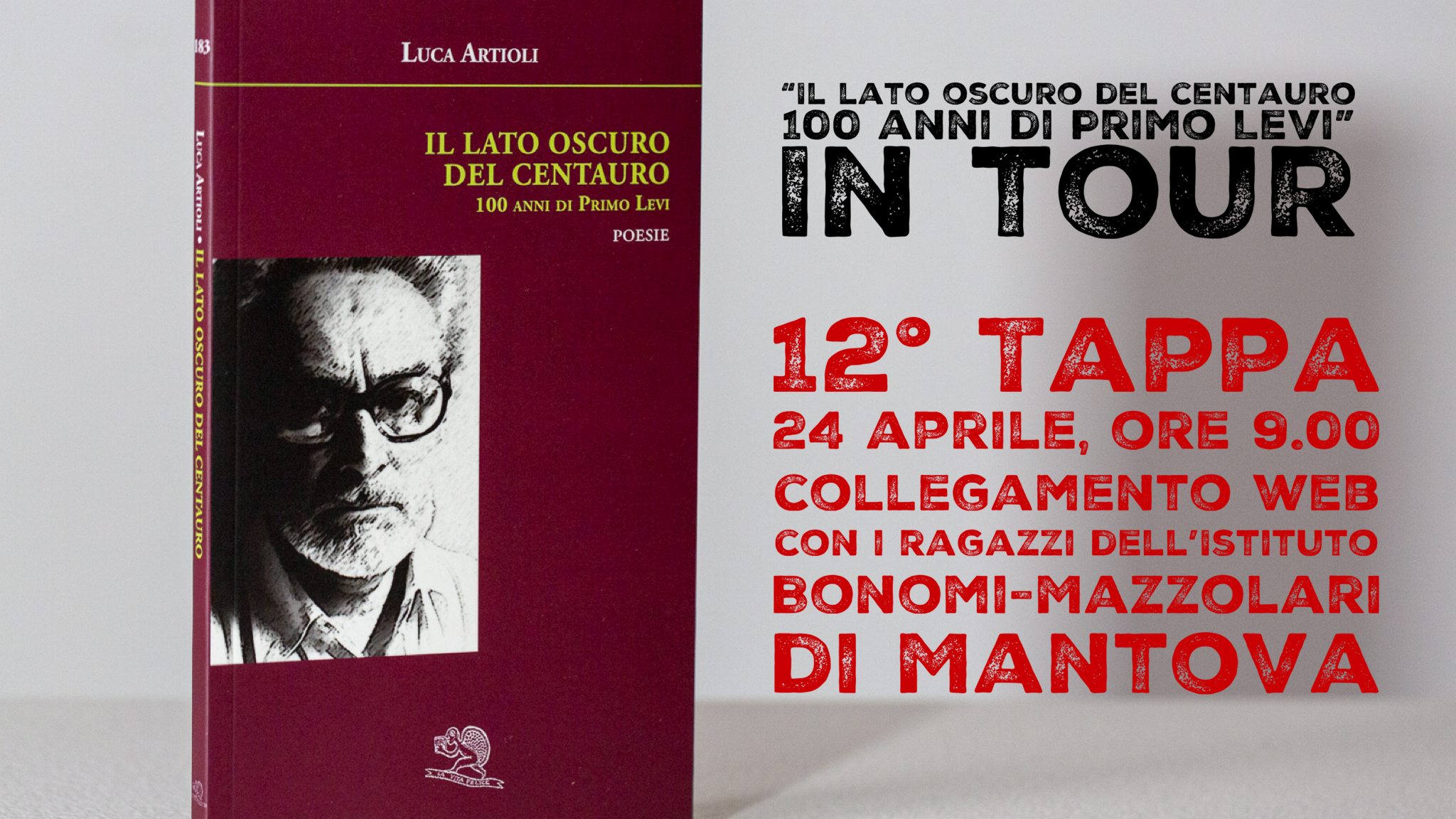

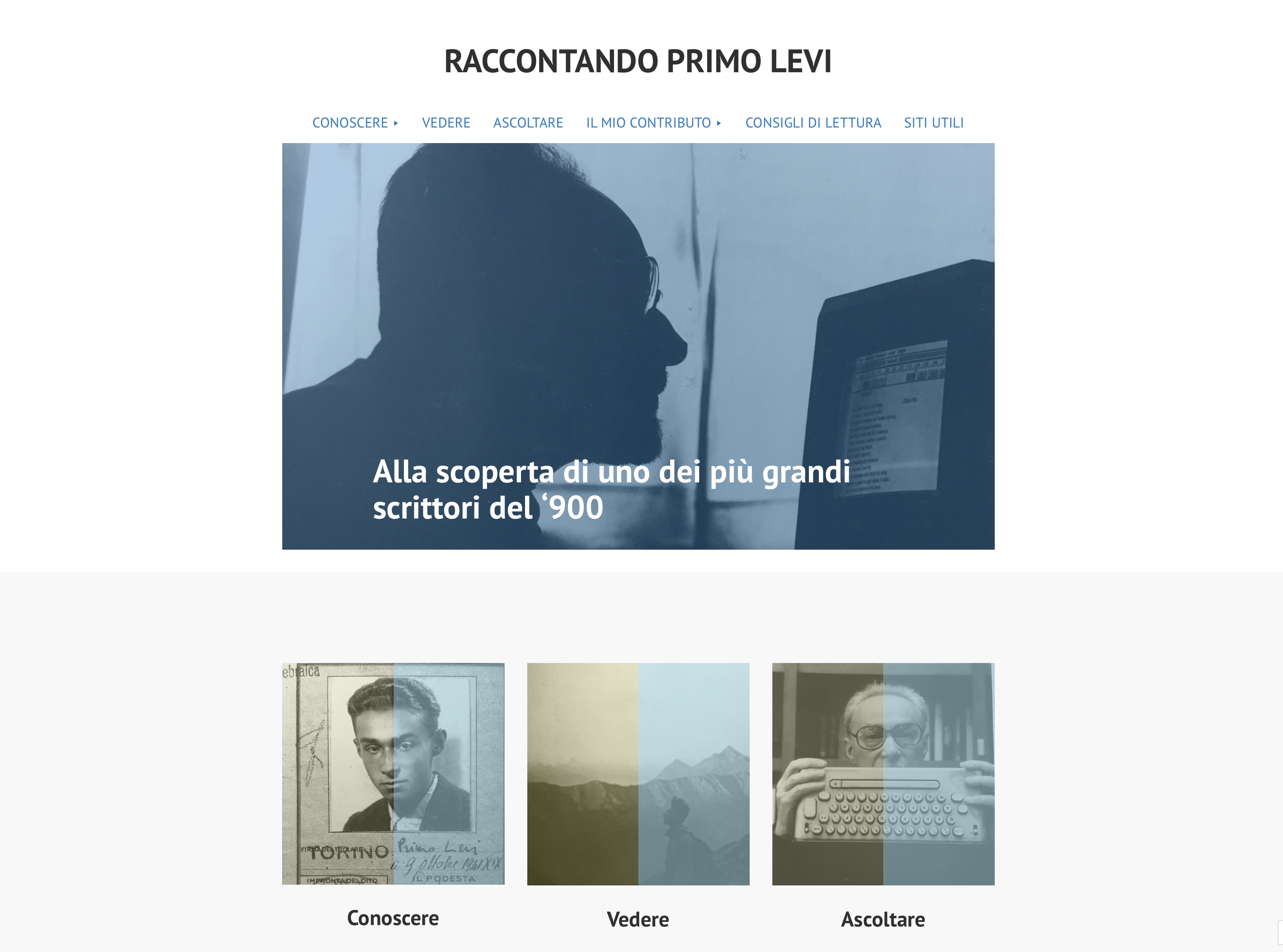

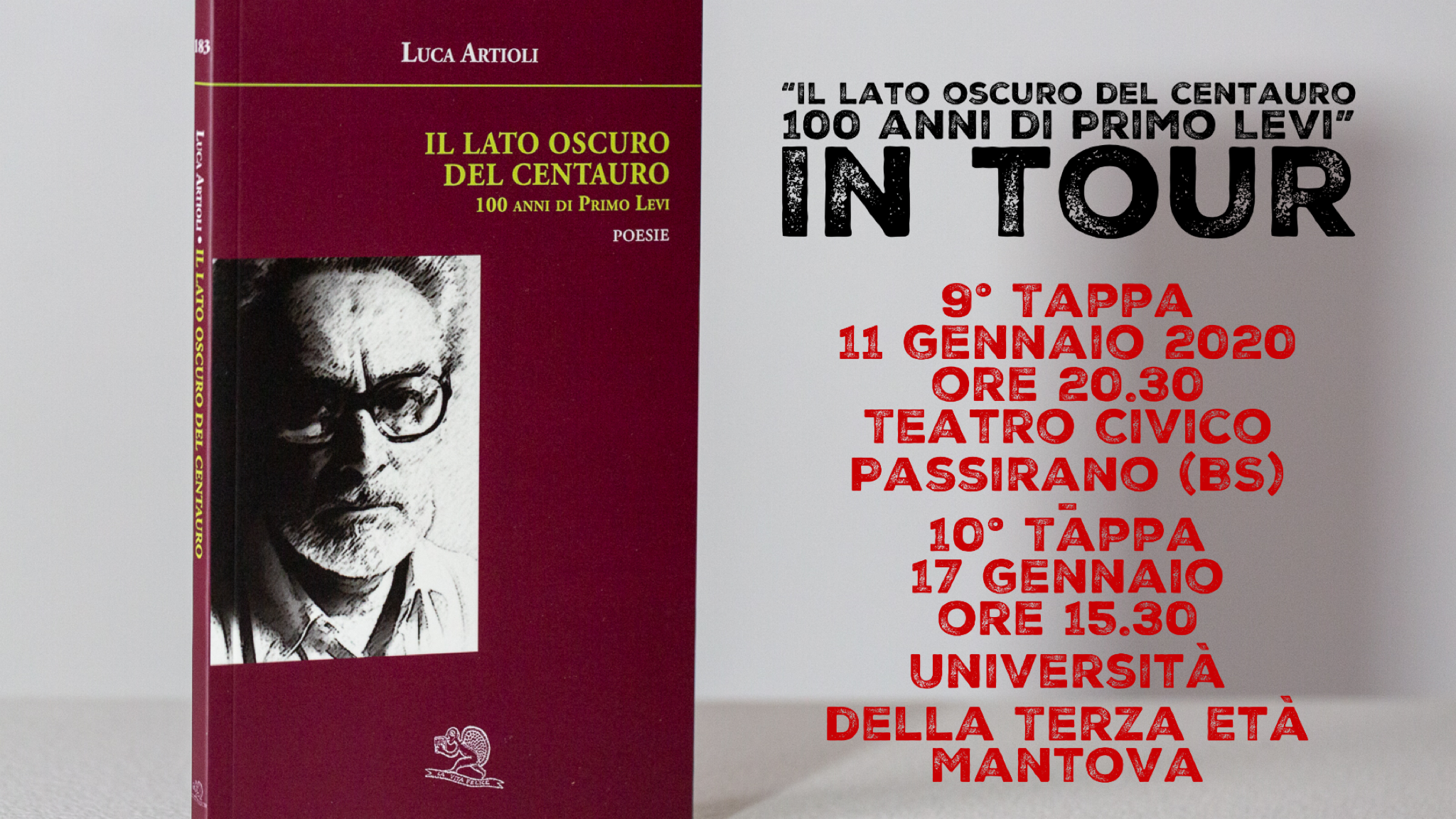
Scrivi un commento